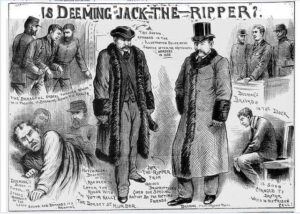VENEZIA – Quando si trovano vittime di un avvelenamento non è sempre facile intuire se si tratti di un’intossicazione casuale o sia il frutto di una mente criminale. Oggi qualche risposta ci viene dalla Polizia scientifica ma, nella Venezia del Settecento, le cose andavano in maniera del tutto diversa.
La sera di sabato 27 settembre 1710, in un Palazzo a San Zulian, il tepore dato dal focolare e dalle pentole ribollenti scaldava la cucina, mentre la città di Venezia iniziava ad addentrarsi nella stagione invernale, che quell’anno si temeva potesse essere particolarmente rigida. Illuminate dalle candele, in quella stanza ricca di profumi c’erano due persone. Una era la “nena” di casa, ovvero la nutrice, tale Caterina Mercante, mentre l’altra era la cuoca, Chiara Pentarina. Tra le due non correva buon sangue, e addirittura si mormorava che Chiara ritenesse Caterina una despota, una che credeva di essere la padrona di casa.
Ma quella sera c’erano altre faccende di cui occuparsi. Il padroncino, Almorò, tornato da Roma da pochi giorni, quella mattina aveva contratto la febbre e quindi, essendo agli inizi del Settecento, un’infezione preoccupava. Come sempre, la nutrice si adoperò a prendersi cura di lui: scesa in cucina – dove la cuoca era intenta ad affettare dei salumi – Caterina iniziò a preparare un brodino, un rimedio naturale che aveva svolto egregiamente il suo compito in molte altre occasioni. Davanti alla sguardo perplesso di Chiara, la nutrice prese una scodella bianca, ci mise dentro un uovo, prese a sbatterlo per un po’, e poi appoggiò la scodella su un tavolo. Si allontanò dal tavolo e si diresse verso l’angolo opposto della grande cucina, dove una credenza conteneva numerose spezie. Come colta all’improvviso da un fugace dubbio, Caterina prima di aprire l’anta della credenza si girò verso la scodella con l’uovo sbattuto. E vide.
Vide la cuoca allungare un braccio verso quella scodella. Caterina si era voltata appena in tempo per vedere il gesto: “Cossa ti ga buttà nell’ovo?” (“cosa hai gettato sull’uovo?)”. “Niente”, rispose Chiara visibilmente innervosita. La nutrice aveva chiaramente visto della polvere cadere dentro la ciotola. Si avvicinò alla cuoca insistendo: “Te ripeto, cossa di ga butta’?”. “Niente de che, un fiantin de farina (nulla di importante, solo della farina)”, rispose Chiara. “Non è possibile”, cominciò a dire la nena. Perché? Perché la nutrice aveva notato che la cuoca non aveva le dita infarinate. Caterina aveva ben capito che c’era qualcosa non chiara in quella faccenda, ovvero che quella polvere era troppo fine per essere farina – come dichiarò ai magistrati successivamente. Subito prese la scodella ed andò a chiamare la padrona di casa: “Parona parona venì a veder” (padrona padrona venite a vedere). Chiara nel frattempo, visto il trambusto, si ritirò nella sua camera. La moglie dell’Albrizzi, che in quel momento si trovava in camera del figlio, sentì chiamare il suo nome e si diresse velocemente verso la cucina, trovando Caterina che le spiegò quello che era successo.
Cos’era accaduto? Nel dubbio che fosse qualcosa di velenoso, le due donne misero la ciotola sul pavimento e chiamarono il gatto di casa. Arrivò un bel soriano che, incuriosito dagli odori di quella cucina, si mise a mangiare ciò che trovò dentro la ciotola. Dopo pochi minuti però si allontanò velocemente, cadde a terra, si rialzò, cominciò a girare su se stesso, e, miagolando, scappò giù dalle scale verso i magazzini. La nutrice e la padrona si guardarono e non ebbero dubbi. Pochi minuti dopo una serva stava andando a chiamare l’Albrizzi.
Girolamo Albrizzi, libraio di professione, era nella sua bottega, a pochi passi da casa. Come quasi tutte le sere, stava discutendo con il suo amico Giuseppe Bonazza, attendente al Dazio del Vin a Rialto. Si stava lamentando della situazione economica quando, concitata, arrivò la serva: “Paron, paron, dovè venir de suzo imediatamente” (padrone, padrone, dovete venire di sopra subito). Rossa in viso e tremante, quella donna era un invito ben chiaro a non fare troppe domande. Salite le scale, venne portato nella camera di suo figlio attorniato dalla madre e dalla nutrice, intente a parlare di qualcosa inerente a un veleno. Gli raccontarono quello che era accaduto. Fu mandato a chiamare Francesco Farina, specier in Campo della Guerra, colui che preparava medicine ordinate dal medico e che conosceva quindi ogni genere di spezie vendute a Rialto. Quando arrivò, gli fu data la scodella e Francesco vide la polvere che era stata raccolta sul fondo. La osservò alcuni istanti e poi se ne portò una piccola quantità sulla punta della lingua, sputandola immediatamente. Subito disse: “Par mi non è arsenico”. Prese la polvere, andò nella sua bottega e dopo circa mezz’ora ritornò. Quella polvere messa sotto una candela scoppiettava ma, non sapendo esattamente cosa fosse, ipotizzò che fosse solimato, anche se aveva bisogno di più tempo per analizzarla bene. Il solimato era argento vivo e veniva considerato un veleno corrosivo potentissimo. Allora si decise di interrogare a dovere la cuoca. Girolamo Albrizzi bussò alla porta della sua camera, entrò, guardò Chiara con disprezzo e le chiese: “Cossa di ga fatto?” ( cosa hai fatto?). Lei cercò di farfugliare invano qualcosa, ma lui agitato le urlò di dirgli cosa avesse messo nella ciotola. Nella stanza era entrato anche lo specier, il quale domandò: “E’ arsenico?”. Lei, con voce bassa, sussurrò che era solo una polvere presa in strada. Ma che polvere? Ammise che era arsenico per avvelenare i topi. Subito dopo però disse che erano sette o otto anni che l’aveva nella scatola e che la stessa polvere l’aveva data ad altre donne e nessuna era stata male. Le chiesero chi fossero queste donne ma disse che non sapeva, non si ricordava. Forse una era morta tempo addietro mentre un’altra era tal Orsetta, moglie di un fabbro che abitava dopo il ponte delle cadene a Castello. Qualche indizio; ma troppo labile per dare certezza che non stesse mentendo.
L’Albrizzi le diede mezzo ducato dicendole: “Andè via da casa nostra” (andate via da casa nostra). Lei non disse nulla, prese le sue poche cose ed uscì. In strada era buio, e sembrava non esserci nessuno in giro. Ma dall’oscurità di un vicolo uscirono alcuni soldati che la presero. Senza dirle nulla, la portarono alle prigioni di Palazzo Ducale.
A questo punto inizia lo stralcio di fascicolo ritrovato nel fondo del Consiglio dei Dieci, con gli interrogatori. La maggior parte di questi processi furono distrutti a seguito dell’occupazione delle truppe francesi, ma alcuni stralci si sono fortunatamente conservati. Perché se ne occupò il Consiglio dei Dieci? Perché era un fatto grave che coinvolgeva una famiglia come gli Albrizzi; inoltre la minaccia proveniva da un veleno. Bisognava quindi comprendere bene cosa fosse accaduto.
Il 7 ottobre l’Albrizzi inviò una lettera al Consiglio dei Dieci per capire il motivo per il quale quella donna volesse avvelenare suo figlio, pregando così il Consiglio di aggiornarlo.
Due giorni dopo si iniziò ad interrogare i testimoni. La prima ad essere sentita fu la nutrice. Non aggiunse molto a quello che già sappiamo. Forse però diede un movente. L’odio che la cuoca aveva nei suoi confronti. Secondo lei mettendo la polvere nel brodo preparato dalla nutrice avrebbe fatto star male il padroncino e questo avrebbe significato metterla in cattiva luce. Si sentono anche i servi di casa e l’11 si decise di sentire lo stesso Albrizzi. La storia è sempre la stessa. Il 13 ottobre si decise di ascoltare anche il figlio Almorò, sebbene lui non potesse aver visto nulla, trovandosi ammalato a letto. Ma poteva far luce su ulteriori moventi non presi in considerazione. Non sapeva veramente il motivo, ma disse ai magistrati che vedendo la polvere sembrava solimato. Il tempo passò. Si arrivò a novembre. La cuoca si trovava nelle carceri di Palazzo Ducale da oltre un mese. Il 6 novembre venne ascoltato dai Capi del Consiglio dei Dieci Antonio Malavitini, capitano delle guardie del Consiglio di Dieci. Era stato lui ad arrestare con i suoi soldati quella donna. Mentre la stava portando in prigione lei gli confidò che non voleva far male a nessuno. Era solo una polvere che voleva buttare nel fuoco e che per un errore era finita nella ciotola. Aggiunse che la usava per lavarsi il viso. Questo è quanto lui giura di sapere della faccenda.
Ci si rende conto che l’unico modo per poter fare chiarezza era capire innanzi tutto che tipo di polvere fosse quella rinvenuta nella ciotola. L’avvogador Lipomano ordinò che fossero consultati due periti di sei speziali, i quali avrebbero dovuto dare un parere su quella polvere.
Furono convocati Vincenzo Mosconi – che lavorava all’Insegna alla Montagna in calle Farza a San Basso – e Girolamo Mantoan – che lavorava all’insegna del Redentore a San Bartolomeo vicino al Ponte di Rialto. Il primo assaggiò sulla punta del dito più volte quella strana polvere e disse che per la sua esperienza non poteva essere venefica altrimenti, assaggiandola, se ne sarebbe accorto.
Girolamo confermò quanto detto da Vincenzo, aggiungendo, tra l’altro, che non poteva essere velenosa perché non aveva nulla nè di corrosivo, nè di materia acra. A questo punto non restava altro che interrogare la stessa cuoca.
Una fredda mattina di novembre, precisamente il 10 novembre, venne prelevata dalle carceri Chiara Pentarina, figlia di Pentarin, barcaiolo da Mestre, nativa di Udine. Indossava ancora gli abiti che aveva la sera dell’arresto. Le prime domande che le vennero rivolte furono semplici. Le venne chiesto dove, da chi e per quale causa era stata arrestata. Con voce tremante disse che era stata arrestata in casa di Gerolamo Albrizzi, libraio a San Zulian dove serviva come cuoca. Era circa l’una di notte quando l’arrestarono. L’avevano accusata di aver gettato veleno nella ciotola. Quella sera di sabato, mentre la “nena” sbatteva un rosso d’uovo in una scodella per far il brodino, mise le mani in tasca per tirare fuori la corona quando uscì la carta nella quale vi era della polvere bianca, con la quale era solita lavarsi il viso. Trovandola inutile la gettò perché andasse a fuoco, ma la carta si aprì e da li sembrò che l’avesse gettata nel brodo. Ma lei era innocente, non voleva far nulla di male.
Ma dove aveva trovato la polvere? La prese ad una signora, si ricordava che il nome era Catte ma non ne conosceva il cognome, solo che abitava in villa di Campo Noghera. Aveva servito solo dieci o dodici giorni da lei e non sapeva dare maggiori informazioni.
Le chiesero se avesse qualcosa contro la nutrice ma lei giurò che non aveva nulla contro di lei e così la riaccompagnarono nella cella. Le accuse erano gravi e i testimoni erano numerosi. I periti scagionavano la cuoca. Inoltre – particolare non trascurabile – il gatto che aveva mangiato l’uovo non era morto. Era stato male tre giorni, vomitando per tutti i magazzini, ma alla fine era vivo. Eppure, per i magistrati non era sufficiente e così il 9 dicembre venne confermato il carcere per Chiara.
Alcuni mesi dopo venne prelevata nuovamente dal carcere.
I Capi dei Dieci ritennero che i mesi passati in cella avrebbero potuto piegarla. La miseria, la prigionia, l’idea di non uscirne viva, forse potevano essere validi motivi per farla parlare. Le chiesero perché voleva gettare la polvere e perché non voleva tenerla nella tasca? Quanto era distante dal fuoco?
Stanca, pallida e visibilmente frustrata dalla situazione, con un filo di voce disse: “Più di un braccio, ero appresso la caponera, qual è poco lontana dal fuoghetto”.
Incalzarono con le domande: “Era vero che aveva gettato lei parte di quella polvere e poi gettato la carta?” Piangendo urlò: “No, poveretta mi, non ho gettato polvere di sorta alcuna in detta scodella, ma fu caso accidentale che s’aprisse la carta e cadesse di detta polvere nella scodella!”
Queste sono le ultime parole di Chiara Pentarina trascritte nel fascicolo; con questa frase si chiude il caso. Di Chiara Pentarina non sappiamo altro. Forse morì in una delle celle di Palazzo Ducale, come spesso accadeva. Un atroce dubbio sulla sua innocenza leggendo il fascicolo ci pervade ma evidentemente, per i Capi del Consiglio dei Dieci, l’ombra del sospetto fu sufficiente a incriminarla.