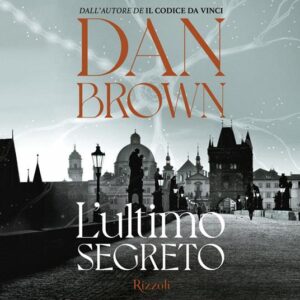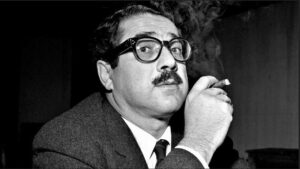La morte di Pio XII, peraltro annunciata da una prolungata agonia, nella tarda mattinata del 10 ottobre 1958 provocò un terremoto nei giornali romani.
Papa Eugenio Pacelli giaceva ammalato nel suo appartamento nel palazzo apostolico di Castelgandolfo, dove per tradizione aveva trascorso parte dell’estate e da dove avrebbe dovuto rientrare in Vaticano. Ma la malattia gli aveva impedito il pur breve viaggio a Roma.
Mentre le sue condizioni si aggravavano di giorno in giorno, i giornali di tutta Italia e anche molti stranieri avevano spedito a Castelgandolfo i propri inviati, che comunicavano con le redazioni chiamando dal posto pubblico telefonico che era nel bar sulla piazza del paese. I telefoni portatili non esistevano ancora, solo le forze armate disponevano di avveniristici radiotelefoni che non potevano certo fare parte del bagaglio professionale dei giornalisti, neanche dei più importanti come gli inviati speciali.
Tenuti fuori dal palazzo apostolico da inflessibili guardie svizzere con tanto di alabarda in pugno, quei cronisti potevano solo tenere d’occhio il palazzo dalla strada, cercando di interpretare cosa stesse succedendo all’interno dal movimento dei sacerdoti, dal viavai dei laici attraverso il portone sbarrato ai più e da altri eventuali segnali significativi.
Il giornale d’Italia, importante testata confindustriale fondata nel 1901 da Sidney Sonnino (un finanziere che sarebbe poi diventato ministro nel governo presieduto da Giovanni Giolitti, e dove chi scrive ha fatto un lungo apprendistato) usciva con la sua edizione più importante nel pomeriggio e quindi era in vantaggio rispetto ai concorrenti del mattino (il Messaggero, il Tempo, L’unità, il Paese a Roma, il Corriere della sera a Milano, la Stampa a Torino, Il resto del Carlino a Bologna, la Nazione a Firenze, il Mattino a Napoli, e non tutti avevano una redazione romana a Palazzo Marignoli in piazza San Silvestro).
Appena fosse arrivata la notizia della morte del Papa il Giornale d’Italia avrebbe potuto pubblicarla subito, in tarda mattinata, e anche nel primo pomeriggio, addirittura a sera, comunque molte ore prima dell’uscita dei giornali all’indomani. E avrebbe fatto da guida soprattutto per le testate estere. Una bella responsabilità.
Il direttore, il siciliano Santi Savarino, aveva mandato a Castelgandolfo il giovane cronista Felice Borsato, che per lo più si occupava di sport. Conscio del nuovo ruolo di inviato, Borsato si era dato un gran da fare e temendo di essere “bruciato” dalla concorrenza, telefonava quante più volte poteva, anche se la situazione ristagnava. Quella mattina annunciò in redazione di essersi garantito la collaborazione di un giovane prete che aveva ceduto alle sue insistenze e aveva promesso di chiudere una certa finestra del corridoio che portava alla camera dove giaceva il papa non appena ne fosse stata accertata la morte e quindi molto prima della comunicazione ufficiale.
Il caso volle, purtroppo, che con Pio XII ancora vivo, un anziano sacerdote del palazzo, passando in quel corridoio, si chiese “Perché questa finestra aperta?” e di colpo la chiuse, stizzito. A quella vista l’inviato Borsato non fu meno veloce e si precipitò al telefono: “Il Papa è morto!”, urlò nel microfono. Dopo pochi minuti, la vecchia rotativa del Giornale d’Italia che sonnecchiava nei sotterranei dello storico Palazzo Sciarra con affaccio su via del Corso, prese a girare consegnando alla storia del giornalismo romano le prime copie dell’edizione straordinaria con la morte del Papa che riempiva tutta la prima pagina.
Il giornale fu subito venduto ai passanti dagli strilloni che da tempo aspettavano quel momento. Mentre piazza Colonna, via del Corso e la stessa galleria Colonna echeggiavano delle grida degli strilloni “Il Giornale d’Italia: edizione straordinaria; il Papa è morto”, da Palazzo Wedekin in piazza Colonna, dirimpettaio di palazzo Chigi sede del governo, il direttore del Tempo dette il via alle sue rotative e in breve i suoi strilloni contrastavano con la voce i colleghi concorrenti e la piazza fu tutto un grido “Il papa è morto!”
E così anche l’edizione straordinaria del giornale fondato nell’immediato dopoguerra dal direttore ed editore Gaetano Angiolillo andò a ruba. La stessa cosa fece Alessandro Perrone, proprietario e direttore del Messaggero, che dal vicino Largo Tritone fece stampare a rotta di collo e diffondere le prime copie. In breve tutto il centro storico di Roma fu invaso dalle edizioni straordinarie dei maggiori quotidiani. La stessa emergenza era scoppiata, intanto, nella moderna tipografia della stampa comunista (l’Unità. Il Paese, Paese Sera) che si trovava decentrata, in via dei Taurini a San Lorenzo.
E quando si scoprì l’equivoco, i furgoncini che stavano portando in entro le copie con la morte del papa, furono richiamati in tempo e così le testate del PCI non furono coinvolte nello “scandalo” della stampa borghese. Ma ugualmente alcune copie sono scampate al macero, e attenti collezionisti vantano tuttora alcune copie di Paese Sera con in prima pagina la notizia della morte presunta di Pio XII.
Ma il papa non era morto. Per rimediare al guaio tutti i giornali coinvolti nell’increscioso equivoco mandarono al macero le copie che non avevano fatto in tempo a ritirare dagli strilloni. Pio XII sarebbe morto solo l’indomani, e il povero cronista fu ritenuto l’unico responsabile di tutto quello sconquasso, che oggi con la rete, gli smartphone, la televisione e i social network non potrebbe succedere.
La morte del Papa non è più lo spauracchio dei giornalisti romani. Il 21 aprile scorso la notizia della morte di Papa Francesco accertata alle 7,30 del mattino si è diffusa nel giro di pochi minuti, e da radio, televisione e web è subito passata all’edizione straordinaria dell’Osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede, l’unico quotidiano cartaceo venduto in piazza San Pietro ai fedeli accorsi da tutta Roma. Lo abbiamo visto tutti al telegiornale.