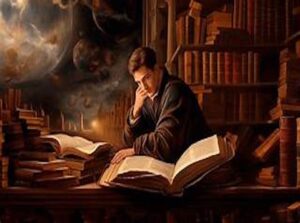ROMA – Udite, udite! Per chi snobba gli Uffizi a Ferragosto, a Pasqua o nei giorni comandati – anche se sono gratis – c’è una alternativa interessante: le gipsoteche del Piemonte [Casale Monferrato con Leonardo Bistolfi; Bistagno con Giulio Monteverde; Rima con Pietro Della Vedova; Verbania con Paolo Troubetzkoy e Savigliano con Davide Calandra]. Vale la pena vederle per tanti motivi.
Primo: senza dire ne’ ai ne’ bai si entra nelle sale, le si visita quasi in solitaria, alla Sgarbi-style, seguiti da guide arci-sollecite o volontari disposti a raccontarvi frizzi e lazzi di vita, come l’ex compagno di scuola di Umberto Eco [«Gli passavo sempre i compiti di matematica…»). Non ci sono code e – meraviglia da sboom di visitatori – calche di turisti tallonanti.
Poi ancora si può percorrere tutta la carriera di un autore – come in una mostra monografica -. Capita così di rivalutare scultori dell’Ottocento tornati di moda con i 150 anni dell’Unità: il simbolista casalese Leonardo Bistolfi era molto apprezzato, per esempio, anche dalla star del tempo Rodin.
Ma soprattutto, andando in gipsoteca, si fa un viaggio nel tempo incappando nei Caruso, Bellini, le Norma, Garibaldi, Vittorio Emanuele II e gli angeli della morte per le tombe monumentali di Milano, Genova o Roma. Si capisce anche che la scultura non è un miracolo di improvvisazione. E’ piuttosto un mix&match di arte e tecnica e comporta un lungo studio che va dal disegno alla terracotta, dal bozzetto al modello in gesso necessario per la trasposizione in marmo o bronzo.
Nel Museo civico di Casale i gessi – lavorati con ditate dallo stesso Bistolfi – sono esposti istruttivamente accanto ai bozzetti. E’ addirittura possibile scovare un negativo a tasselli, l’unico conservato. Nell’immancabile Statua equestre di Garibaldi si notano invece le traguardature [puntini e crocette lasciati dall’artista per riportare le misure sull’opera definitiva in marmo]; nel Funerale di un eroe i chiodini e nel Ritratto di Cesare Lombroso le giunture [i segni lasciati dalla matrice].
Da un punto di vista filologico è anche interessante scoprire varianti, crucci, tic e ripensamenti in corso d’opera: per esempio il Monumento a Carducci di Bologna realizzato da Bistolfi ha avuto molte integrazioni rispetto al gesso preparatorio. Nella scultura funebre per il cimitero di Staglieno a Genova – la Vita e la morte – Giulio Monteverde [scultore bistagnino attivo a Roma] è costretto a coprire con un velo il lato B della fanciulla (la Vita) ghermita dallo scheletro (la Morte). Insomma, non era più l’epoca controriformista dei braghettoni di Michelangelo. Ma quasi.