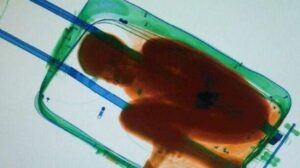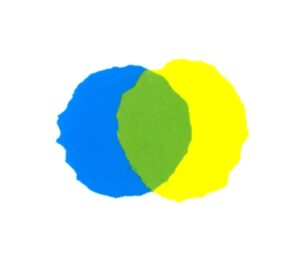ROMA – Una società che si chiude su sé stessa, che erge mura di cinta sulla spiaggia, negandosi il mare, pur di non vedere la propria immagine riflessa nell’altro, è una società del terrore, che uccide dentro e fuori la città.
Che affonda, con i tagli ai soccorsi, all’accoglienza e all’amore, barconi pieni di centinaia di esseri umani, che fa dei propri membri dei morti culturali, svuotandoli del valore dell’incontro, della solidarietà e della capacità di provare emozioni. Togliendosi il gusto di vedere cose belle, di immaginare un mondo migliore. Cosa possono fare i nostri governi dopo la tragedia dell’altra notte? Cosa possono fare le persone comuni? Cosa può fare questo giornale? Cosa possono fare i suoi lettori? Cosa posso fare io? Non è più tempo per le lacrime da coccodrillo, si è toccato il fondo: occorre essere umani.
Non lo è chi rimanda la palla a Bruxelles, chi finge che aver chiuso Mare Nostrum non sia stata una colpa imperdonabile, chi ci specula sopra, chi vuole la guerra – in mare, in Libia, in Afghanistan, in Siria, in Iraq -, chi crede di avere la democrazia nelle tasche e si sente in dovere di donarla come fosse Babbo Natale e i popoli fossero bambini senza storia, genitori e modi di stare insieme.
La notizia dei novecento cuori a cui è stato tolto il battito mi è stata data da un ragazzo migrante di 18 anni nel Centro di accoglienza dove lavoro e da allora non ho trovato le parole. Al seguirsi di dirette e della sadica ennesima conta dei morti, ho avuto fissa in testa questa domanda: cosa possiamo fare? E se le cose di tutti i giorni cercavano di allontanarla, era mia figlia di un anno, il suo viso innocente, a farmela tornare più forte di prima fino a provocare una risposta, a fare emergere delle parole. Sono contrario ai funerali passerella, sono contrario ai lanci di agenzia. Sono contrario alle inchieste del momento che se ne vanno via dopo una settimana. Ho una proposta precisa, che avanzo insieme a Dazebao, ma che resta aperta: va bene il minuto di silenzio, ma se vogliamo ricordare le vittime, se vogliamo cambiare qualcosa, prendiamo i nostri figli, troviamo il tempo e portiamoli a giocare sul prato. Giochiamo a un gioco che viene da lontano e troviamo la forza e la gioia di parlargli di quanto è bello conoscere l’altro, di quanto è bello stare insieme con persone che vengono da lontano.
E’ da mesi che penso a un Festival degli aquiloni migranti, con i migranti che conducano laboratori per i nostri bambini, laboratori per realizzare aquiloni, per colorarli e farli volare alti. Ecco, io partirò da qui, dal mio quartiere, ma di Festival degli aquiloni migranti se ne dovrebbero organizzare uno per città e se non ci saranno aquiloni, ma altri giochi tradizionali sarà ancora più bello. Credo che siamo chiamati a ricordare e a cambiare il nostro modo di essere, e a farlo insieme all’altro. I nostri occhi occidentali e adulti, però, non sanno più portare certe immagini indietro nel tempo e i nostri sensi non sanno più sentire vicine altre persone Allora quello che possiamo fare è mandare un messaggio ai nostri figli, costruire un momento per loro che sappia di convivenza, di curiosità, di gioco. Aquiloni migranti in ogni città, con gli aquiloni o senza, basta giocare a un gioco che viene da lontano con i nostri bambini e se a farlo si è in tanti e insieme – uomini, donne, artisti, scrittori, musicisti, fratelli – è ancora meglio. Sono convinto che stare con gli occhi al cielo, su un prato e non costretti in mare aperto, a vedere gli aquiloni e poi le stelle può avere più senso di tante cerimonie, gelide analisi e tante ipocrisie.