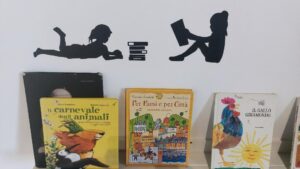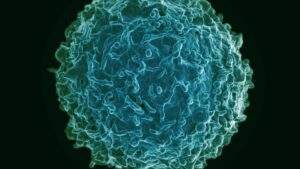L’Alzheimer è al centro di una fervente attività scientifica che spazia dai test per una diagnosi precoce a terapie volte a rallentare il declino cognitivo.
Questa malattia neurodegenerativa, che colpisce circa il 5% degli over 60 e conta in Italia circa 500mila pazienti (secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità), è oggetto di intense ricerche.
Ricerche stimolate, non solo da esigenze sanitarie e sociali, ma anche da enormi interessi economici.
Tuttavia, è lecito chiedersi se i progressi siano reali o se siamo abbagliati dal miraggio di una cura definitiva.
“Non c’è nessun miraggio”, afferma Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze dell’Irccs San Raffaele di Roma.
“Siamo consapevoli che il traguardo di una cura completa è ancora lontano, ma rispetto a qualche anno fa c’è un rinnovato interesse per la diagnosi precoce e la cura dell’Alzheimer, un interesse che ha significative implicazioni economiche e organizzative.”
Ogni settimana emergono nuovi studi su test diagnostici che mirano a identificare la malattia prima della comparsa dei sintomi. Questi studi, pur scientificamente importanti, nascondono anche interessi commerciali, con il potenziale lancio di kit diagnostici che potrebbero avere un mercato globale enorme, soprattutto tra gli over 50.
Negli ultimi tre anni, l’FDA americana ha approvato tre anticorpi monoclonali, sebbene due di questi non siano stati approvati in Europa a causa della loro scarsa efficacia e dei significativi effetti collaterali.
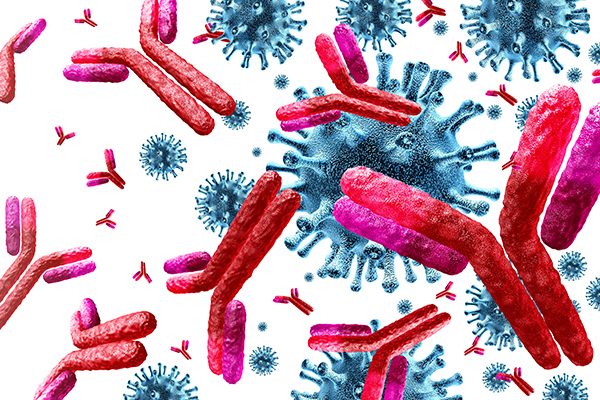
Rossini sottolinea l’importanza di un approccio coordinato simile a quello adottato per i vaccini anti-Covid, dove tutte le parti coinvolte, dalle autorità politiche alle industrie farmaceutiche, dovrebbero collaborare per raggiungere risultati tangibili in tempi più brevi.
Gran parte delle ricerche recenti si concentra sull’identificazione di biomarcatori – tramite esami del sangue, neuroimaging, test genetici o elettroencefalogrammi – che possano diagnosticare precocemente la neurodegenerazione.
Tuttavia, questi biomarcatori sono spesso testati su popolazioni a rischio di sviluppare demenza, come gli anziani con “Mild Cognitive Impairment” (MCI), che hanno un rischio dieci volte superiore di progredire verso l’Alzheimer rispetto ai loro coetanei.
Ma qui emerge una questione cruciale: molti individui con biomarcatori positivi non svilupperanno mai i sintomi della malattia.
Questo crea un dilemma etico e sociale, poiché una diagnosi biologica potrebbe distruggere la vita di una persona, soprattutto se giovane, senza che la malattia si manifesti mai clinicamente.
È quindi fondamentale sviluppare test che possano prevedere con precisione chi svilupperà la malattia e chi no, riducendo al minimo i falsi positivi.
Infine, Rossini evidenzia l’importanza di studiare i fattori di resilienza che permettono ad alcuni individui di resistere alla neurodegenerazione, aprendo così nuove vie terapeutiche.
Per quanto riguarda i trattamenti attuali, tre anticorpi monoclonali – Aducanumab, Lecanemab e Donanemab – sono stati approvati dall’FDA, ma solo negli Stati Uniti, a causa della loro efficacia limitata e degli alti costi.
Questi trattamenti richiedono somministrazioni endovenose e monitoraggi regolari per identificare eventuali effetti collaterali come edemi o microemorragie. Sono in fase di sperimentazione anche altre terapie, inclusi trattamenti per via sottocutanea o orale.
In Italia, il progetto “Interceptor”, che coinvolge 19 centri da nord a sud, mira a sviluppare un panel di biomarcatori sostenibili che, insieme ai test neuropsicologici, permetteranno di diagnosticare l’Alzheimer in fase precoce.
Questo progetto rappresenta un modello organizzativo che potrebbe essere il primo al mondo nel suo genere.
In conclusione, Rossini sottolinea che uno degli obiettivi principali della ricerca dovrebbe essere quello di prolungare il periodo di autonomia dei pazienti, alleviando così il carico emotivo, sociale ed economico che oggi grava pesantemente su familiari e caregiver.
Bloccare l’evoluzione della malattia nelle sue fasi iniziali potrebbe migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.