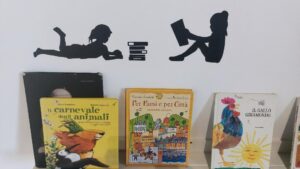La costellazione Hermes Pathfinder, sviluppata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha raggiunto con successo l’orbita grazie alla missione Transporter 13 di SpaceX.
Il lancio è avvenuto il 15 marzo alle 7:43 (ora italiana) dalla Vandenberg Space Force Base, in California, USA.
Hermes Pathfinder: un passo avanti nell’astrofisica spaziale
Hermes Pathfinder (High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites) è una costellazione formata da sei nanosatelliti CubeSat, progettati per avanzate ricerche nel campo dell’astrofisica multi-messaggero ad alta energia. Questi piccoli ma potenti satelliti opereranno in triplette per rilevare eventi astronomici improvvisi, come i lampi di raggi gamma, e inviare rapidamente notifiche alla comunità scientifica globale.
I sei CubeSat sono stati integrati su una piattaforma di rilascio Ion, sviluppata dalla società D-Orbit, e posizionati su un vettore Falcon 9. Una volta collocati su un’orbita eliosincrona a 500-520 km di altitudine con un’inclinazione di 97,44°, i nanosatelliti verranno rilasciati uno al giorno per una settimana.
Una collaborazione tra enti di eccellenza
Il progetto Hermes Pathfinder è finanziato principalmente dall’ASI, con il contributo di importanti istituzioni scientifiche italiane, tra cui:
- Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
- Politecnico di Milano (Polimi)
- Università degli Studi di Cagliari (UNICA)
Il Politecnico di Milano ha svolto un ruolo chiave in diverse fasi del progetto, dalla progettazione all’integrazione dei satelliti, fino ai test ambientali. Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico, ha sottolineato l’importanza del laboratorio ASTRA del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER) nella ricerca aerospaziale.
Un nuovo approccio alla scienza spaziale
Secondo Roberto Ragazzoni, Presidente dell’INAF, la costellazione Hermes Pathfinder rappresenta un nuovo paradigma nell’astrofisica spaziale: “Questi piccoli satelliti creano un telescopio ‘virtuale’ grande quanto l’orbita in cui volano, con un diametro di quasi 14.000 km. È la prima volta che tale tecnica viene applicata a sorgenti di raggi X e gamma provenienti anche da galassie al di fuori della Via Lattea”.
Il software di bordo per l’elaborazione dei dati è stato sviluppato dall’Università di Tubinga, mentre i payload a raggi X/gamma sono stati progettati e calibrati presso le strutture dell’INAF a Roma e della Fondazione Bruno Kessler a Trento.
Un’infrastruttura globale per il monitoraggio spaziale
Grazie alla sua avanzata capacità di co-puntamento, la costellazione Hermes Pathfinder sarà in grado di monitorare costantemente il cielo, trasmettendo le coordinate degli eventi cosmici in pochi minuti. Il sistema sfrutta:
- La rete satellitare Iridium per la trasmissione dati
- Una rete di stazioni di terra dedicate, tra cui quella di Katherine (Australia) gestita dall’Università della Tasmania, in collaborazione con l’Università di Melbourne e l’Università di Masaryk
- Il Mission Operation Center (MOC), realizzato da Altec Torino su finanziamento ASI
- Il Scientific Operation Center (SOC), ospitato presso lo Space Science Data Center (SSDC) dell’ASI a Roma
Le operazioni della costellazione saranno supportate da due stazioni di terra dedicate, una situata presso il Politecnico di Milano a Spino d’Adda (Cremona) e l’altra in Australia.
Un successo per l’Italia nello spazio
Teodoro Valente, Presidente dell’ASI, ha dichiarato: “Il lancio di Hermes Pathfinder è un nuovo successo per la comunità spaziale italiana. Grazie alla competenza della nostra accademia, ricerca e industria, stiamo dimostrando come l’Italia sia in grado di guidare missioni spaziali innovative”.
Questa missione rientra nel più ampio programma europeo Horizon 2020, con il quale tre delle sei unità di volo sono state sviluppate grazie ai finanziamenti della Commissione Europea.
Con Hermes Pathfinder, l’Italia si posiziona in prima linea nello sviluppo di nanosatelliti avanzati per l’osservazione dell’universo, aprendo la strada a nuove modalità di esplorazione spaziale rapide, economiche e altamente efficaci.