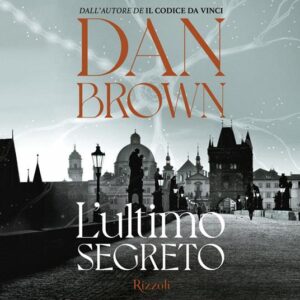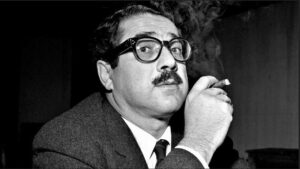Nel nord-est della Francia, in Lorena, c’è un festival del cinema italiano nato nelle miniere francesi che sta per compiere mezzo secolo di vita.
Lo conoscono in pochi perché ha avuto una nascita non facilissima, una crescita costante ma lenta, ha dovuto imparare a fare tutto da solo, poco amato in casa (in Francia) e poco apprezzato anche nel paese (l’Italia) al quale è dedicato attraverso il suo cinema.
Villerupt è una cittadina di diecimila abitanti, al confine con il Lussemburgo, vicino a Germania e Belgio, fra i monti della Lorena, la regione che fin dalla Grande Guerra è stata contesa e più volte occupata e liberata da Francia e Germania sempre in guerra fra loro. Dove una volta c’erano le sbarre della frontiera ci sono ancora le vecchie sedi della dogana che alternativamente furono tedesca o francese.
Boschi e campi coltivati si perdono a vista d’occhio. Il nome: i francesi lo pronunciano Vilru, con la u lombarda, come in menu, i tedeschi lo dicono come si scrive, Villerupt, che in italiano suonerebbe Citta rotta, ma l’etimologia non corrisponde perché la città non è affatto in rovina.
Ecco la sua storia.
Nei primi decenni del Novecento nelle viscere della Lorena si allungava il filone minerario della tedesca Rhur. Per decenni a Villerupt sono emigrati migliaia di italiani provenienti dalle regioni più povere, attirati da un buon salario con alloggio in decorose case operaie a schiera, e una settimana di ferie all’anno, per tornare a casa e riabbracciare la famiglia.
E così è stato fino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando il giacimento di ferro si è esaurito costringendo alla chiusura la società francese che aveva assunto tutti quegli immigrati.
Un po’ alla volta alcuni fra gli italiani, soprattutto i più giovani, sono rimpatriati, ma molti fra i più anziani sono rimasti anche da pensionati. Si sentivano, ormai, perfettamente integrati, parlavano francese sia pure con accento abruzzese o siciliano, avevano messo su famiglia, l’Italia era lontana e mancava terribilmente a tutti.
Consapevoli di aver dato un valido contributo allo sviluppo della metallurgia francese (dalle loro mani uscivano le rotaie dei treni) ma la lontananza da casa pesava.
Anche perché a fine giornata di lavoro, quando sulle case scendevano le brume del nord e la pioggia sottile sembrava non dovesse mai smettere, a quegli emigrati italiani la città non offriva altra occasione di svago se non il piccolo bistrot dov’era possibile bere una buona birra belga o il gioco al coperto delle pétangue, le nostre bocce.
C’erano anche due piccole sale cinematografiche che proiettavano solo film francesi.
Un giorno la grande novità: un intraprendente emigrato dalla Campania prima di rientrare dalle ferie si è messo in valigia, in due tonde scatole metalliche, le “pizze” di un nostro film di qualche anno prima che dal proiettore di una di quelle piccole sale, aveva offerto al pubblico di operai la graditissima sorpresa di una serata cinematografica tutta italiana.
Fu un successo che venne ripetuto altre volte, finché un giorno ad una coppia di amici francesi di origine italiana venne la luminosa idea di organizzare con regolarità le proiezioni di film italiani non troppo vecchi.
Era nato così un festival che ha avuto una genesi romantica: per venire incontro agli immigrati che non avevano ancora familiarità con la lingua, il professore Oreste Sacchelli, originario di una famiglia di anarchici di Aulla, in provincia di Massa Carrara, docente di italiano all’Università di Nancy, a pochi chilometri da Villerupt, grande competente di cinema italiano, che si dedicò all’impresa con la collaborazione di Antoine Compagnone, il proiezionista delle due sale del paese.
Insieme misero su alla buona il festival che dura tuttora anche perché negli anni ha subìto notevoli cambiamenti. Nato povero, il festival del cinema italiano di Villerupt negli anni si è arricchito di notorietà e di mezzi materiali, il vicino Lussemburgo si è rivelato un po’ alla volta uno sponsor generoso.
La scelta della data in cui far svolgere il festival era stata obbligata: tutti i mesi dell’anno erano occupati da manifestazioni cinematografiche che si contendevano i film da presentare, dal Festival di Cannes alla Mostra di Venezia, dal Cinema nuovo di Pesaro agli Incontri di Sorrento, dalle Giornate di Taormina, ma soprattutto si doveva tener presente la disponibilità del pubblico di immigrati italiani che avevano in miniera turni tutt’altro che flessibili.
E così si decise per il “ponte” dei Santi, il primo week end di novembre, e quello di Villerupt sarebbe stato l’ultimo festival in calendario, e tutti i minatori ebbero la possibilità di andare alle proiezioni.
Non era facile trovare film italiani che piacessero a quel pubblico particolare: dovevano essere storie d’amore o d’azione, anche i western-spaghetti che andavano di moda o i film comici più popolari, ma i distributori italiani si facevano pagare comunque salati anche quelli di serie B.
C’era, poi, il problema di far conoscere il Festival anche fuori dalla Lorena. Di qui l’idea di rivolgere un invito all’Anica, l’associazione che riunisce i produttori italiani di film, telefilm e video, di partecipare non tanto alla ricerca dei film da proiettare quanto, per farsi conoscere, di guidare al festival alcuni ospiti particolari: attori, attrici, registi, sceneggiatori, distributori, giornalisti.
Anche perché la stampa francese al festival di Villerupt non dedicava molta attenzione, trattandolo come un evento locale, al massimo dieci righe nelle pagine della provincia.
Il caso volle che l’incarico di portare registi e attori italiani al festival in Lorena toccò all’autore di questi ricordi che subito venne definito dai francesi il “nostro agente” non all’Avana ma a Roma, da dove ogni anno partiva alla testa di una piccola delegazione i cui componenti apparivano sempre perplessi sulla destinazione: “Villerupt? Ma dov’è?” si chiedevano l’un l’altro dopo aver ricevuto l’invito a partire.
Particolarmente interdetta fu, un anno, Maria Grazia Cucinotta, giovanissima ma già molto apprezzata per aver interpretato Il postino al fianco di Massimo Troisi, che dal pubblico fu accolta con molta curiosità ma anche favore.
I primi anni del festival furono un’avventura. Nato dall’entusiasmo di pochi, aveva bisogno della partecipazione appassionata di tanti volontari (benevoles erano citati nel programma, insieme con gli sponsor).
E ogni anno, durante quel week end allungato dei primi di novembre, l’arrivo dei cinematografari italiani con il loro improvvisato capogruppo era una festa, e più d’una bottiglia di autentico champagne veniva stappata nella sala del consiglio comunale (dove si sarebbero svolte parte delle proiezioni) dal comitato di accoglienza presieduto dal sindaco e con tutta la giunta comunale schierata al completo. Grande entusiasmo e reciproca simpatia, e il festival prese il largo.
Non mancarono le brutte sorprese: un anno, aperto il pacco delle “pizze” di un film appena arrivato dall’Italia si scoprì che ne mancava una, proprio l’ultima, quella con la scena finale senza la quale il film non si sarebbe potuto proiettare se non si voleva che il pubblico insorgesse e distruggesse la sala.
Il film doveva essere proiettato quel sabato sera. Per fortuna era in arrivo da Roma il volo della Luxair, la compagnia belga del Lussemburgo dove faceva scalo l’aereo con a bordo la delegazione italiana di attori e registi, e al giornalista che la capeggiava fu chiesto di recuperare subito la pizza mancante e di aggiungerla al bagaglio personale, non senza qualche difficoltà per convincere i doganieri di entrambi gli aeroporti che non si trattava di contrabbando internazionale di pellicole proibite, ma di una situazione alla Nuovo cinema Paradiso.
Comunque, l’ultima indispensabile pizza arrivò appena in tempo e la proiezione fu salva! Giuseppe Tornatore non avrebbe inventato nulla, a Villerupt era successo davvero!
La prima sera con gli ospiti stranieri ebbe un debutto imprevisto: era il 27 ottobre 1990 quando arrivò anche a Villerupt la notizia della morte improvvisa di Ugo Tognazzi. Con ammirevole prontezza, gli organizzatori decisero di rendere omaggio all’attore dedicandogli l’edizione del festival e mettendo d’apertura alle proiezioni un film da lui interpretato e di cui si erano procurati tempestivamente una copia in italiano.
Il giornalista non resistette alla tentazione di dare subito la notizia all’Ansa: “Il festival di Villerupt primo al mondo rende omaggio a Ugo Tognazzi”. L’indomani su tutti i giornali italiani il nome di Villerupt era nelle cronache sulla morte dell’attore, e molti in Italia nell’ambiente del cinema si chiesero: “Villerupt? Ma dov’è?”.
Era fatta: da quell’anno la fila di celebrità del cinema italiano invitate al festival lorenese si allungò sempre più.
A scorrere l’albo d’oro della manifestazione si trovano i più bei nomi del cinema italiano di quegli anni: Dino Risi, Luigi Magni, Giuliano Montaldo, Ettore Scola, i fratelli Paolo e Vittorio Taviani, Nanni Moretti, Pupi Avati, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Giuseppe Piccioni, Riccardo Milani, Paolo Virzì, Cristina Comencini, Philippe Leroy (per lui, francese, si fece un’eccezione, ormai in Italia di casa), Michele Placido, Valerio Mastandrea, Francesca Archibugi, Massimo Ghini, e decine di altri nomi più o meno famosi.
L’accoglienza per tutti, celebrità o meno noti, era spartana ma commovente. I primi anni si dormiva all’Hotel de la Poste, sulla strada principale del paese, vecchiotto ma confortevole e pieno di scricchiolii perché tutto l’edificio era di legno, e la domenica nella sala da pranzo, tolte le tovaglie, i tavoli si riempivano di coppie di silenziosi giocatori di scacchi venuti da tutta la regione, richiamati non tanto dal festival del cinema quanto dalla buona cucina.
Fra una proiezione e l’altra si pranzava e si cenava nei bistrot del paese vecchio che servivano gustosissimi piatti tipici della cucina lorenese. A sera si tirava a far tardi a La Cave, una mini-balera ricavata da una cantina, appunto cave in francese, dove si faceva buona musica e i boccali di birra tedesca e i bicchieri di vino francese andavano via come l’acqua fresca.
Per diventare, come poi è stato, una vetrina del cinema italiano, il festival lorenese si era imposto di invitare i giovani registi a presentare la loro opera prima, (come fu per Paolo Sorrentino, che portò con sé il suo primo film reduce dalla Mostra di Venezia), i vecchi maestri a riproporre i loro capolavori, (come fu per Luciano Emmer che, anzianissimo, a Villerupt si è rivisto il suo indimenticato Terza liceo).
E agli autori affermati o non ancora popolari ha offerto l’occasione di avere un incontro ravvicinato con un pubblico-campione, utilissimo per conoscere i gusti delle platee, quando erano solo le sale ( e non, come oggi, la televisione) a determinare il successo di ogni novità destinata al grande schermo.
Ma come riempivano le giornate lorenesi i vip saliti da Roma? Anche questo era nei compiti del capo-gruppo giornalista. Data la strategica posizione mitteleuropea di Villerupt c’era solo l’imbarazzo della scelta: in treno in mezz’ora eri a Trier, in Germania, l’antica Treviri dei romani, dove si visitò la casa natale di Carlo Marx, un ovattato appartamento di poche stanze nel centro storico con il pavimento di legno e tanti cimeli dell’autore del Capitale.
Oppure, un’ora di macchina fino a Reims, a visitare oltre alla cattedrale le cantine dove invecchiano milioni di bottiglie di champagne, o le storiche città francesi più vicine come Metz e Nancy. Infine, con la Grande Vitesse era possibile un salto a Parigi, per gustare alla Cupole una veloce tartare o dare uno sguardo panoramico dalla grande torre di Montmartre avendo tutta la città sotto gli occhi.
Il Festival di Villerupt si sta avvicinando al traguardo del cinquantesimo anniversario, avendo goduto di molte innovazioni. La festa paesana delle origini è oggi una rassegna culturale di tutto rispetto, con frequenti incursioni nel confinante Lussemburgo con i suoi accoglienti alberghi e ristoranti.
E continua a inanellare un’edizione dopo l’altra con sempre grande partecipazione di pubblico. Purtroppo, il ricordo dei minatori italiani si è affievolito anno per anno, come si era esaurito il filone della miniera di ferro.