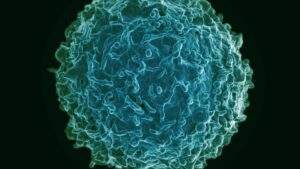La colonna di autocarri tedeschi risaliva lentamente via Livorno. Veniva dai baraccamenti che lungo i binari della ferrovia Roma-Firenze, appena fuori dalla stazione Tiburtina, erano stati prima dei militari della nostra Guardia di Finanza e poi dei tedeschi che vi si erano acquartierati in vista del ripiegamento al nord.
Dalle finestre del quarto piano la scena sembrava quella di un film: sui camion scoperti i soldati con l’uniforme della Wermacht sedevano allineati, una fila davanti all’altra, fra le ginocchia il fucile al quale appoggiarsi, stanchi, avviliti. Con il fucile, uno particolarmente giovane teneva stretto anche un orsacchiotto giallo, che spiccava sul grigio-verde della divisa. ”Chissà a chi l’ha preso quell’orsacchiotto – aveva commentato mia madre con un tono accorato che raramente le avevo sentito – sicuramente a un bambino, forse ebreo” aveva concluso a voce alta.
Era il 5 giugno 1944, il giorno della liberazione di Roma. Quella colonna di autocarri tedeschi doveva essere una delle ultime ad imboccare via Salaria per risalire l’Italia verso nord. Da sud stavano entrando a Roma gli alleati. Sotto le finestre di mia zia Nannina, che abitava in via Carlo Felice, una strada importante del quartiere San Giovanni compresa fra due basiliche, Santa Croce in Gerusalemme da una parte e San Giovanni in Laterano dall’altra, stavano in quelle stesse ore sfilando i carri armati della Quinta Armata anglo-americana in arrivo da Cassino. Un incredibile, assurdo cambio della guardia nella Roma città, appena, aperta. La zia Nannina esultava al telefono: “Sono arrivati gli americani, la guerra è finita!”. Mio padre le aveva confermato lo sfilamento dei tedeschi sotto le nostre finestre. Un passaggio storico che in casa mi arrivò sul filo di quel telefono appeso al muro in corridoio fra la cucina e la camera da letto. Era grosso, nero, di bachelite, fissato alla parete come un’erma di marmo dei Musei Capitolini. Stavo per compiere sette anni, e quindi non posso dire di aver conosciuto la guerra, troppo piccolo, ma occhi e orecchi ben aperti mi hanno lasciato ricordi ed emozioni indelebili.
In via Livorno c’è la casa dove ho trascorso l’infanzia, la fanciullezza, l’adolescenza e la maturità fino ai trent’anni. Su un’ideale mappa della città, via Livorno e le altre cento strade e piazze qui nominate sono tanti puntini uniti, come in un diagramma enigmistico, dal filo di una vita, la mia, che si è svolta tutta a Roma. Come in tutte le città prese di mira dai bombardamenti alleati, anche in via Livorno 27, durante la guerra, c’era un rifugio anti-aereo. Erano le cantine del palazzo, nelle quali erano stati messi dei pali di legno a sostenere il soffitto. Se una bomba ci avesse centrato, quel rifugio sarebbe diventato la tomba di tutti gli inquilini. Ma a quei tempi di meglio non si poteva pretendere. C’era l’autarchia, dicevano tutti per spiegare le ristrettezze economiche del Paese. Oltretutto i quindici appartamenti che si aprivano sui cinque piani erano stati dati in affitto prima della guerra e l’importo era rimasto immutato (affitto bloccato, si diceva) per gli anni successivi. Quindi costava poco e alla proprietaria, Edda Ciano, figlia di Mussolini e moglie del ministro degli esteri Galeazzo Ciano, rendeva ben poco. Tanto che anni dopo si decise a vendere l’intero palazzo.
Quando suonava l’allarme che preannunciava l’arrivo dei bombardieri (la sirena svettava sul tetto di un palazzo che dava su piazza Bologna e si sentiva in tutto il quartiere) chi voleva scendeva al rifugio. C’erano delle panche, si sentivano i rumori del bombardamento, chi chiacchierava, chi pregava, i bambini piangevano o giocavano ignari del brutto momento. Fra i tanti ordigni che i bombardieri sganciavano sulla città c’erano anche i cosiddetti “spezzoni incendiari”, bombe al fosforo che esplodendo appiccavano un incendio difficile a da spegnere. Ingenua difesa contro gli “spezzoni” erano dei sacchi di carta pieni di sabbia distribuiti in ogni palazzo dall’Unpa, l’Unione Nazionale Protezione Aerea, l’ente governativo preposto alla salvaguardia delle città a rischio di bombardamento. Un sacchetto di sabbia fu a lungo sul pianerottolo del quarto piano, davanti a casa nostra. Ben presto la carta si ruppe e sulla sabbia che ne uscì fu per me un’occasione insperata per farci un percorso per il mio trenino elettrico, quando c’era la corrente, che spesso mancava. Dopo i primi, ai bombardamenti si finì per abituarsi. Con sconsiderata imprudenza, qualcuno non andava più al rifugio in cantina ma all’opposto saliva in terrazzo, dove c’erano i lavatoi condominiali (che le rare donne di servizio chiamavano “le fontane”, al ricordo di quelle sulla piazza dei rispettivi paesi da dove provenivano, spesso dall’Abruzzo, dall’Umbria, dalla Sardegna). Da lassù si assisteva ad uno spettacolo pirotecnico che sembrava fatto di fuochi artificiali, mentre erano i proiettili traccianti della contraerea che sparava contro le “fortezze volanti” americane che sganciavano grosse bombe. Un giorno un proiettile di cannone cadde inesploso sul marciapiede dinanzi al salumaio Vitali, in piazza Lotario, dopo aver urtato fortunatamente di striscio la facciata del palazzo. Corremmo tutti a vederlo, prima che gli artificieri lo portassero via. Per me un’altra indimenticabile immagine di guerra. Quella guerra, che senza grandi drammi ha comunque condizionato i miei primi anni di vita in via Livorno. (1- continua)
Da “Via Livorno”, La Quercia editore, autobiografia di Sandro Marucci, giornalista RAI e tutor della scuola di giornalismo dell’università LUISS