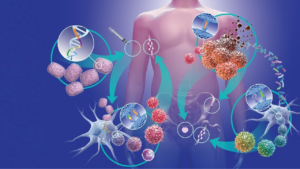Ogni anno l’inquinamento atmosferico causa milioni di morti premature, ma il tema resta sorprendentemente marginale. Una riflessione sul perché le persone non vogliono sapere cosa respirano e su quali strumenti abbiamo (e non usiamo).
⸻
Introduzione
L’inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio per la salute globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno oltre 7 milioni di persone muoiono prematuramente a causa dell’esposizione a inquinanti presenti nell’aria, sia outdoor che indoor. Di queste, 4,2 milioni sono legate all’inquinamento esterno e 3,8 milioni all’inquinamento domestico, in ambienti con scarsa ventilazione e uso inefficiente di combustibili.
Nonostante queste cifre, la qualità dell’aria resta un argomento marginale nel dibattito pubblico e ancora poco integrato nei processi decisionali, sia in ambito urbano che aziendale. Eppure, si tratta di un problema trasversale, che riguarda salute, ambiente, economia e giustizia sociale.
⸻
Il paradosso della sostenibilità
Mentre concetti come “Green Deal”, “transizione ecologica” e “ESG” vengono promossi a livello europeo e aziendale, la qualità dell’aria che respiriamo – elemento primario e universale – sembra rimanere fuori dai radar. Troppo spesso relegata a voce tecnica o a parametro occasionale, è percepita come invisibile e quindi trascurabile.
Eppure, è proprio questa invisibilità che ne aumenta la pericolosità. Le particelle fini (PM10, PM2.5), gli ossidi di azoto (NOₓ), l’ozono troposferico, il benzene, il monossido di carbonio e altri inquinanti sono sostanze a effetto cumulativo e a lungo termine, spesso prive di manifestazioni acute, ma con impatti devastanti.
⸻
Perché non vogliamo sapere cosa respiriamo
L’indifferenza verso l’aria che respiriamo ha radici profonde, che toccano la psicologia, la cultura e la percezione del rischio:
• Negazione difensiva: accettare che l’aria che respiriamo ogni giorno possa danneggiarci genera ansia, per questo tendiamo a ignorarla.
• Normalizzazione del disagio: sintomi come stanchezza, allergie, mal di testa vengono spesso interpretati come “ordinari”, senza collegarli all’ambiente.
• Mancanza di dati accessibili: l’assenza di sensori diffusi e di strumenti informativi quotidiani limita la capacità delle persone di comprendere e reagire.
⸻
Gli ambienti più esposti… e meno controllati
I luoghi dove la qualità dell’aria dovrebbe essere monitorata con la massima attenzione sono spesso i più trascurati:
• Scuole e asili: ambienti con ricambio d’aria limitato e alta densità di presenza. I bambini sono particolarmente vulnerabili agli inquinanti.
• Strutture sanitarie: reparti ospedalieri, ambulatori e RSA, dove soggiornano soggetti fragili, raramente dispongono di sistemi di monitoraggio continuo.
• Luoghi di lavoro: ambienti industriali, uffici open space e laboratori tecnici non sono sempre conformi alle raccomandazioni internazionali sulla qualità dell’aria indoor.
⸻
Il segnale (dimenticato) della pandemia
Durante la crisi COVID-19, la ventilazione e il ricambio d’aria sono diventati elementi centrali per la prevenzione sanitaria. Tuttavia, questa consapevolezza si è dissolta con il ritorno alla normalità. Oggi il tema sembra nuovamente assente, nonostante le evidenze scientifiche accumulate.
L’OMS ha classificato il particolato atmosferico come cancerogeno certo per l’uomo, mentre l’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che solo in Europa l’inquinamento dell’aria causi oltre 300.000 decessi prematuri ogni anno.
⸻
Verso un cambio di paradigma
Per riportare al centro la qualità dell’aria servono azioni sistemiche:
• Educazione ambientale diffusa e trasversale, già nelle scuole primarie;
• Campagne di sensibilizzazione strutturate e basate su dati reali e localizzati;
• Incentivi pubblici e privati per l’adozione di tecnologie di monitoraggio ambientale;
• Integrazione obbligatoria del monitoraggio ambientale nei protocolli ESG e nei bilanci di sostenibilità, anche in relazione alle più recenti Direttive europee, come la Direttiva UE 2881, che prevede l’obbligo di rendicontazione degli impatti ambientali, sociali e di governance per le imprese e gli enti pubblici.
L’adozione di sensori certificati e sistemi intelligenti di analisi non è più un’opzione tecnologica, ma una necessità etica e normativa.
⸻
L’aria è un bene comune, ma non percepito come tale. Il paradosso è evidente: più cresce l’inquinamento, più cala l’attenzione collettiva. Per uscire da questa spirale, serve un cambiamento culturale profondo, che coinvolga cittadini, imprese e istituzioni.
Sapere cosa respiriamo è un diritto. Monitorare la qualità dell’aria è un dovere. Ignorarlo oggi significa trascurare la salute di domani.