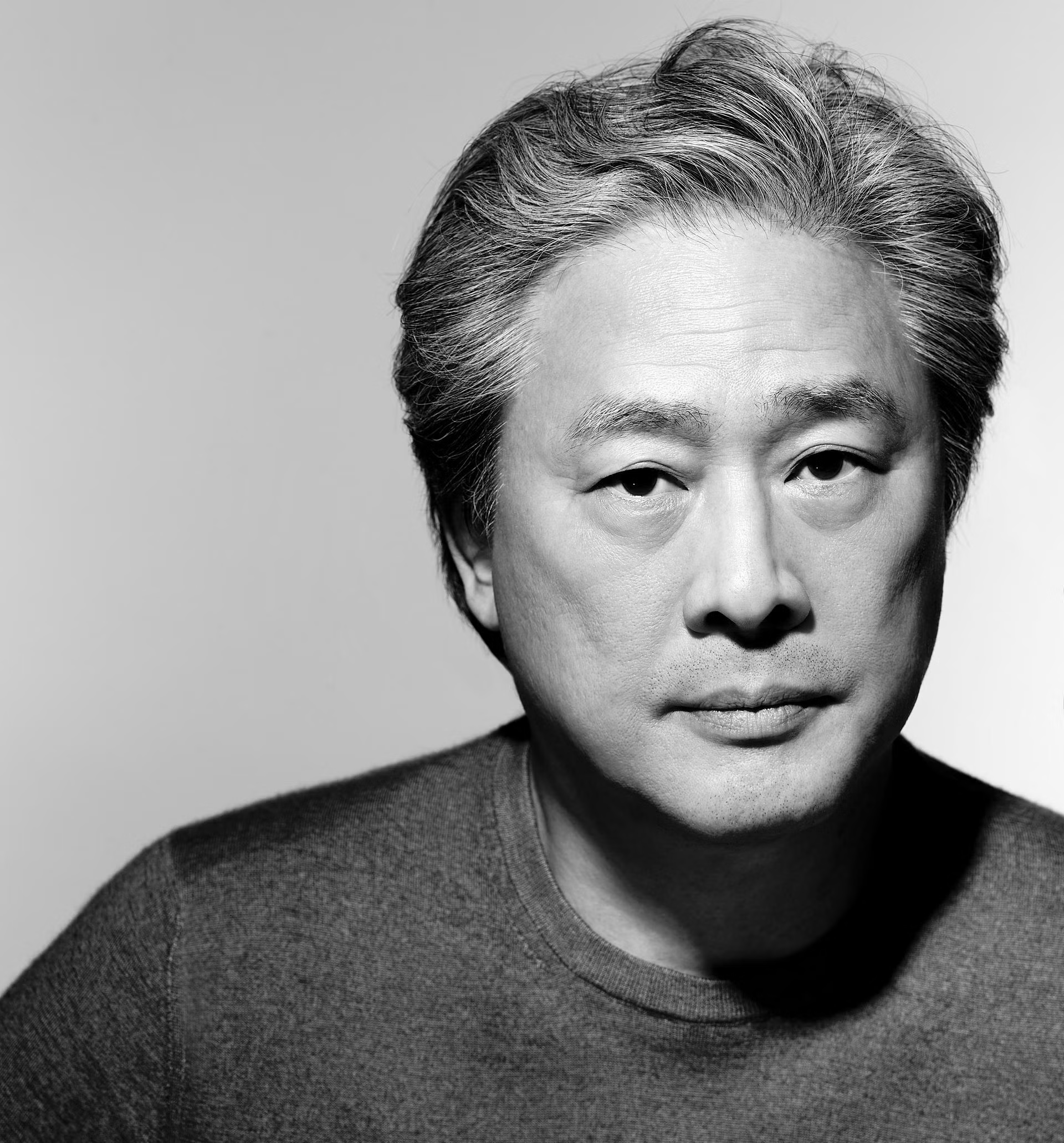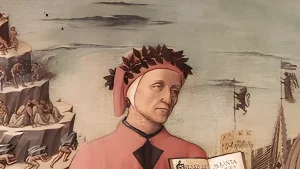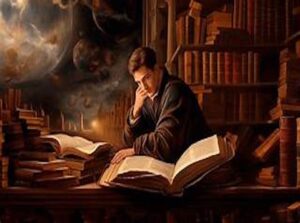Affrontare una diagnosi oncologica rappresenta una delle esperienze più destabilizzanti per una persona. Oltre all’impatto fisico della malattia e delle cure, il paziente si trova a confrontarsi con un complesso sistema di emozioni, paure e cambiamenti esistenziali. La dimensione psicologica in oncologia è un elemento fondamentale, spesso trascurato nelle prime fasi, eppure determinante per la qualità della vita e l’efficacia delle terapie.
Paziente oncologico, quando si usa la medicina nucleare?
Nel percorso diagnostico e terapeutico del paziente oncologico, le soluzioni per medicina nucleare rappresentano uno strumento di primaria importanza. Si tratta di una branca della diagnostica per immagini che utilizza radio farmaci, sostanze debolmente radioattive, per visualizzare il funzionamento degli organi e dei tessuti in modo preciso e precoce.
In oncologia, le applicazioni della medicina nucleare sono molteplici. La più conosciuta è la PET/TC (Tomografia a Emissione di Positroni associata alla Tomografia Computerizzata), mirata a individuare sedi tumorali primarie e secondarie, valutare l’estensione della malattia (stadiazione), monitorare la risposta ai trattamenti e rilevare eventuali recidive.
Il vantaggio della medicina nucleare è la possibilità di ottenere una valutazione funzionale della patologia, a differenza delle sole immagini morfologiche fornite da altri esami.
L’impatto della malattia sulla psicologia
Ricevere una diagnosi di tumore genera inevitabilmente una reazione emotiva intensa. Nella fase immediata, la persona può sperimentare un senso di smarrimento, paura, incredulità, o anche un momentaneo stato di blocco emotivo. La malattia oncologica, infatti, ha profonde ripercussioni sul piano psicologico e relazionale.
Le preoccupazioni si estendono alla qualità della vita, all’impatto sulle relazioni familiari, lavorative e sociali. Il paziente può vivere una frammentazione dell’identità, un senso di perdita di controllo sul proprio futuro, un cambiamento del proprio ruolo sociale e familiare. Questo processo interiore è spesso accompagnato da sintomi psicologici significativi.
Non di rado, tali reazioni vengono sottovalutate o messe in secondo piano rispetto alle esigenze cliniche immediate. È ormai riconosciuto quanto sia determinante includere il supporto psicologico all’interno del percorso terapeutico oncologico. Il benessere mentale influisce direttamente sulla compliance alle terapie, sull’adesione ai protocolli clinici e sul proprio stato d’animo.
Crisi emotiva e il coping
Il modo in cui un paziente affronta la diagnosi e il percorso oncologico è influenzato dalla sua capacità di coping, ovvero dalle strategie cognitive e comportamentali messe in atto per gestire la crisi emotiva. Non esiste una risposta univoca, ogni individuo reagisce in base alla propria personalità, alla rete di supporto sociale e alle esperienze pregresse.
Gli studi in ambito psico-oncologico hanno identificato diverse strategie di coping utilizzate dai pazienti oncologici:
- disperazione e impotenza (hopelessness/helplessness): caratterizzata da alti livelli di ansia e depressione, questa modalità comporta una percezione di assenza di controllo e un senso di sconfitta;
- spirito combattivo: si osservano risposte proattive, l’adozione di comportamenti costruttivi e una moderata emotività. Il paziente cerca attivamente soluzioni, collabora con i medici e mantiene un atteggiamento fiducioso;
- accettazione stoica: caratterizzata da atteggiamenti fatalistici e scarsa emotività, ma senza tratti depressivi marcati;
- negazione: in alcuni casi, il paziente rimuove o minimizza la gravità della malattia, rifiutando la consapevolezza del problema.
Il riconoscimento del tipo di coping adottato è importante per orientare l’intervento psicologico e per personalizzare il supporto fornito dall’équipe medica. L’obiettivo è quello di aiutare il paziente a trovare un equilibrio tra consapevolezza, speranza e realismo, promuovendo al contempo una comunicazione con i familiari e i medici.