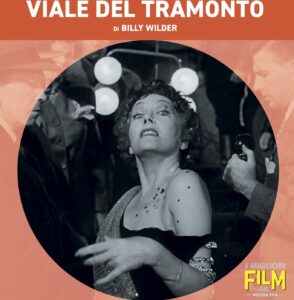Un team dell’INAF, insieme alle Università di Padova e dell’Aquila, ha individuato un nuovo meccanismo che sfida le teorie sulle esplosioni stellari.
Una scoperta tutta italiana sta rivoluzionando la comprensione delle supernove di tipo II. Un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con la collaborazione delle Università di Padova e dell’Aquila, ha analizzato in dettaglio le caratteristiche della supernova SN 2024bch, esplosa a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra e osservata nel febbraio 2024.
I risultati, pubblicati sulla rivista internazionale Astronomy & Astrophysics, mettono in discussione un principio considerato fino a oggi fondamentale nello studio delle esplosioni stellari: la correlazione tra la presenza di righe spettrali strette e l’interazione tra il materiale espulso dalla stella e il gas circostante.
Una supernova “asociale” che non ama interagire
Durante 140 giorni di osservazioni, la supernova SN 2024bch ha mostrato righe di emissione molto strette, un segnale che di solito identifica le cosiddette supernove interagenti, cioè avvolte da un denso guscio di gas. Questi fenomeni sono spesso associati a sorgenti di neutrini ad alta energia, ma il team dell’INAF ha scoperto che, in questo caso, le apparenze ingannano.
L’energia emessa dalla supernova, infatti, non deriva da collisioni violente tra materia e gas, bensì da processi radioattivi tradizionali. Per questo gli studiosi l’hanno soprannominata una “supernova asociale”, poiché si comporta in modo indipendente e silenzioso, senza bisogno di interazioni esterne per brillare.
Il mistero spiegato dalla fluorescenza di Bowen
A svelare l’enigma delle righe spettrali strette è stato un fenomeno poco considerato fino a oggi: la fluorescenza di Bowen.
Come spiega Leonardo Tartaglia, ricercatore dell’INAF e primo autore dello studio:
“Abbiamo applicato uno sguardo non tradizionale e privo di pregiudizi. Per la prima volta in questo tipo di transienti, dimostriamo che il meccanismo principale è la fluorescenza di Bowen, un processo noto da decenni ma mai applicato a supernove di questo genere.”
Questo fenomeno può essere paragonato a una eco luminosa ad alta energia: la radiazione ultravioletta prodotta dall’esplosione eccita gli atomi di elio attorno alla supernova, che trasferiscono l’energia ad altri elementi come ossigeno e azoto. È proprio questo trasferimento di energia a generare le righe di emissione osservate, senza alcuna interazione fisica violenta.
Una scoperta che cambia le regole dell’astronomia
L’analisi del team INAF costringe ora gli scienziati a ricalibrare i modelli di classificazione delle supernove.
“Per almeno una parte di questi transienti, l’interazione non è il motore principale delle emissioni. Questo ha implicazioni rilevanti per l’astronomia multi-messaggera: la supernova SN 2024bch, non mostrando segni di interazione, non può essere una sorgente di neutrini ad alta energia,” aggiunge Tartaglia.
La forza della ricerca italiana
La campagna osservativa è stata condotta grazie a una rete di strumenti dell’INAF:
- il telescopio Copernico da 182 cm e lo Schmidt da 92 cm dell’Osservatorio di Asiago (INAF Padova),
- il Wide-field Optical Telescope (WOT) dell’INAF d’Abruzzo, installato a Campo Imperatore,
- e il satellite Swift, che ha monitorato la supernova nella banda ultravioletta.
Questa scoperta, firmata interamente da studiosi italiani, è una dimostrazione concreta dell’eccellenza della ricerca scientifica nazionale, capace di mettere in discussione le teorie consolidate e di aprire nuovi scenari per lo studio dell’universo.