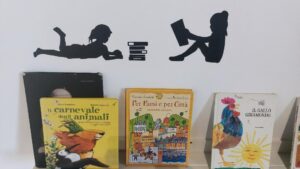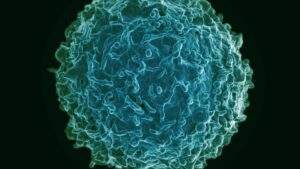Il magma rappresenta una potenziale fonte di energia semi-infinita. Tuttavia, per sfruttarlo, è fondamentale comprendere la sua posizione sotto la superficie terrestre e i suoi movimenti. Per la prima volta, grazie a tecniche innovative di geodesia satellitare, un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell’Università di Pisa è riuscito a studiare il magma a profondità mai esplorate, analizzando il suo movimento e la sua risalita verso la superficie.
La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, è stata condotta dal dottor Alessandro La Rosa e dalla professoressa Carolina Pagli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Collaboratori della ricerca includono il professor Freysteinn Sigmundsson della University of Iceland e studiosi provenienti da Cina, Francia e Regno Unito.
“La possibilità di ricavare energia dal magma è una realtà concreta allo studio in paesi come l’Islanda”, afferma Carolina Pagli.
“Per misurare i movimenti millimetrici della superficie terrestre, abbiamo utilizzato principalmente la tecnica dell’Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), combinata con il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), per ottenere una visione tridimensionale dei movimenti della crosta terrestre”. Il monitoraggio satellitare, durato dal 2014 al 2021, si è concentrato sul rift dell’Afar, una depressione nel Corno d’Africa tra Gibuti, Eritrea, Somalia ed Etiopia, dove si trova il punto più basso del continente africano.
I risultati hanno rilevato un sollevamento della crosta terrestre di circa 5 mm/anno, rivelando l’origine comune di fenomeni superficiali molto distanti tra loro.
“Nel nostro studio abbiamo dimostrato come l’apporto di magma nella crosta avvenga a impulsi, in luoghi diversi ma contemporaneamente,” spiega Alessandro La Rosa. “Nello specifico, l’afflusso di magma è avvenuto simultaneamente in quattro diversi luoghi, distanti decine di chilometri e a profondità comprese tra 9 e 28 km, causando il sollevamento della superficie su un’area di circa 100 km”.
Carolina Pagli si dedica da sempre alla ricerca sui vulcani attivi tramite tecniche di geodesia satellitare. Dopo aver conseguito il PhD alla University of Iceland, dove ha studiato i vulcani attivi e l’influenza del ritiro dei ghiacciai sulla produzione di magma, ha continuato il suo percorso alla University of Leeds nel Regno Unito.
Tornata in Italia grazie al programma ministeriale Rita Levi Montalcini, è ora professoressa associata di Geofisica della Terra Solida presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Alessandro La Rosa, già dottorando e assegnista di ricerca nel gruppo di Carolina Pagli, è attualmente Research Fellow al GFZ-Potsdam in Germania.