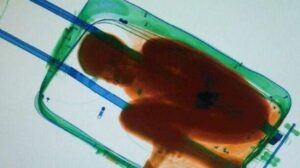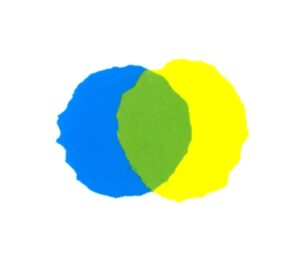ROMA – Piazza del Popolo alle 6 e 40 di mattina, pulita, vuota, fresca. I nostri passi sembrano lasciare orme. Le gambe tremano e la strada sembra allungarsi. Via del Corso, le serrande chiuse, i turisti dormono, i ragazzi ancora nelle loro case di periferia.
Andiamo avanti verso la Commissione. E’ un giorno di quelli in cui essere italiano è molto lontano dall’essere un richiedente asilo. E’ un miraggio. Cerco di parlare del più e del meno, con rispetto, mascherato di timidezza. Poi l’appuntamento con altri ragazzi al bar. Siamo cinque, un romano dalle lontane origini argentine, due ivoriani, un guineano e un maliano. Il mio caffè è dolce, quello del ragazzo di Conakry è amaro: “mi devo fare forza”, gli altri prendono del semplice latte caldo. Il barista non sa quanto prezzarlo: “non lo chiede più nessuno!”. Poi un centinaio di passi verso la corte suprema, quei giudici di una vita intera. La caserma sa di centro storico, le pareti di un giallo anticato, la porta in legno scuro, le grate alle finestre di ferro battuto. E’ presto, abbiamo appuntamento alle 9.00. Seduti su dei gradini contiamo i secondi, chi ripassa la sua storia a memoria, chi si appunta sul palmo della mano, nera, con una penna di inchiostro blu le date più importanti, chi lo fa con la penna nera, perché ha la fortuna di avere i palmi leggermente più chiari. Sembra di essere a scuola prima di un compito in classe, ma lo si vive come a teatro, prima di andare in scena. Boul fuma la sua ultima sigaretta, un ms, poi ne scrocca una a me, una di quelle sottili, infine chiede ad un moldavo, anche lui in attesa dell’apertura del commissariato, un po’ di tabacco. Le cartine di scorta ce le ha sempre con sé. Non ha bisogno di filtri. Ha paura di essere rimpatriato, di ricevere un diniego. E’ insonne da giorni, ogni notte è preda di incubi.
Di giorno con l’avvocato ha preparato la sua memoria, tra articoli di giornale, visite che certificano le sue cicatrici, colloqui psicologici ecc., di notte ha ripercorso i suoi drammi, emotivamente, sudando i suoi mali, le sue disavventure. “Ho il terrore di rientrare, non voglio essere ucciso”. Ha commesso un piccolo reato e lo ha fatto involontariamente, nel suo villaggio la giustizia è regolata dalle famiglie e lui scappando ha messo in difficoltà la sua. “Ora non so se ho una madre, se ho un fratello, non so se sono vivi. Non so se ad uccidermi saranno loro o le persone della famiglia a cui ho fatto il danno”. Nei giorni precedenti abbiamo condiviso la verità, la sua verità ed oggi la racconterà a testa alta. Ha scontato la sua pena dormendo nel Sahara, subendo violenze nelle carceri algerine e in quelle libiche. Lavorando in condizioni disumane a Rosarno e mendicando asilo per 11 mesi, in attesa di essere ascoltato. Infine la convocazione pochi giorni dopo il compimento della maggiore età. Sorte sfortunata che è toccata anche ad altri due ragazzi del gruppo. Niente tutele da minori, niente presentazione degli educatori, nessun accompagnatore del comune. Soli con la loro maturità di fronte all’Italia. Di fronte a una porta ci sono dei guardiani, come quello della Legge kafkiano. I migranti domandano: “Posso entrare?”
E il più delle volte il guardiano, commissario, risponde: “No. non è il tuo momento”. Loro ci riprovano e lui si ripete: “No, non è il tuo momento”. Eppure da quella porta solo loro possono entrare. Anzi già sono entrati. In Guinea ci sono manifestazioni forti, morti su morti, la polizia è esercito e la giustizia fai da te. Povertà a gogò e guerriglie civili si sono ripetute così tanto da non essere considerate guerre dal nostro paese. In questa terra a dicembre 2011 le elezioni sono state posticipate a tempo indeterminato. In Mali i Tuareg hanno sconvolto il Paese, chiedono l’indipendenza del Nord, entrano nelle città, le devastano, le occupano e vanno avanti. Milioni di profughi schizzano per tutta l’Africa. La politica finge di rispondere con nuove elezioni politiche, ma oramai da quelle parti nessuno crede più ai loro governanti. Tutti sanno che i militari possono avere il potere formale quando vogliono, ma che gli stessi militari non riescono a tenere testa ai Tuareg. Che ad un esercito di Stato si sta contrapponendo un esercito di nomadi rinforzati da chi ha fino a poco tempo fa combattuto in Libia. Un caos totale. In Costa D’avorio è un gioco delle tre carte. Carta nera perde sempre. Fino a poco tempo fa la guerra civile era riconosciuta. Il precedente Presidente, dittatore, perseguitava i djoula, non riconosceva le sconfitte elettorali. Ora il nuovo presidente è di origine djoula, ma tutti sanno che durerà poco, l’etnia più debole non ha migliorato le sue condizioni di vita e solo il terrore tiene il filo teso. A cadenza settimanale lo spettro di un colpo di Stato o scuse per nuove false elezioni aleggiano nell’aria. Il vento spazzerà via l’illusione e lo farà prima che chi ha vissuto un decennio di guerra possa rintracciare i suoi pezzi di famiglia, ricostruirsi una casa.
Sono le 9.00, saliamo al primo piano, le stanze dell’audizione sono pronte, mancano i commissari, ma ci dicono che stanno arrivando. Alla macchinetta del caffé ci sono alcuni mediatori, “Bonjour mes frères!”. “Bonjour” gli rispondono. Poi il gelo. Capisco ora perché nessuno al centro vuole fare il mediatore, capiscono la responsabilità di questo ruolo, “Qui sono dei traduttori e basta poco per dare un significato o un tono diverso a ciò che vogliamo esprimere”.
C’è un’interché (significa amico), che è chiuso nel fumo della sua coscienza. “Mentire o non mentire?”. E’ il minore, non sa se rivelare o meno la vera data di ingresso in Italia. Due notti fa mi ha detto: “Se vuoi aiutarmi non chiedermi di ripassare la mia storia, ma tranquillizzami”. Non regge il confronto con gli occhi, non lo fa per timore di essere messo a nudo, ma al contempo ogni qualvolta i nostri sguardi si sono incrociati ho sentito che anche io avevo il bisogno di abbassare lo sguardo. Non avrei saputo trasmettergli sicurezza per più di cinque secondi, comprensione per più di dieci, ascolto per pochi minuti. Lacrime e giudizi avrebbero determinato la brillantezza dei miei occhi. Ieri abbiamo parlato della sua vita in Mali e ancora chiusura. Ma diversa. Non voleva ricordare. Dopo ore di incoraggiamenti ha trovato la forza. Le sue parole erano macigni tirati da sospiri. Ha visto i ribelli uccidere i suoi genitori. E’ stato rapito e separato dalla sorella. Aveva 12 anni. Con le lacrime agli occhi: “Questa è la mia storia, non c’è bisogno che la ripassi, mi fa male, e non è facile parlarne”. Tutto il resto conta poco. Contano poco le fughe e le date. Ma ci siamo, è quasi il suo turno. “Cosa facciamo, cosa diciamo al tutore? Seguiamo la storia che hai preparato con l’avvocato o vuoi correggere qualcosa?”. “Tu che dicia, Morrisio?”
Gli spiego che la Commissione avrà a sua disposizione i fascicoli della Questura, ma che ad ogni modo è una sua decisione dire quello che vuole. “Ok, so che fare!”. Due ore di attesa, poi lo vedo uscire, il commissario lo saluta con il sorriso e gli fa: “Ora stai tranquillo, bello!”. Poi gli strizza l’occhio. Il tutore lo tiene per mano. E lui riprende colore, mi sorride e: “Credo sia andata bene, Dio sa”. Moralmente ha vinto, non ha rispettato gli schemi burocratici. Ha chiesto dell’acqua per superare la gola secca, ha parlato lentamente, fissando il commissario. Ha ribaltato le carte, si è messo a nudo. Non ha dato importanza ai luoghi, ai giorni, al tempo, ha posato il suo cuore sul tavolo. Ha commosso la giuria. Non era Cannes, Venezia, San Remo, era una Commissione per richiedenti asilo. Lui non è un attore, loro non sono addetti allo Show Business. Un uomo e altri uomini, uomini che sentono migliaia di storie ogni anno. La sua storia è fatta di emozioni, la sua vita di sofferenze, ha chiesto di essere giudicato per ciò che ha vissuto non per numeri. Chi sa, forse ha fatto bene. Questa è la dignità di un migrante. Poi: “Grazie, mi avevi tranquillizzato!”.
Gli ivoriani hanno vita difficile, le loro udienze sono più brevi. Sembra che i commissari non abbiano voluto prendere in considerazione le problematiche relative alla loro permanenza in Libia. “Non è il vostro Paese, è inutile che ci raccontiate di quello che vi è capitato da quelle parti”. E poi: “Ora il vostro Presidente è djoula, perché volete restare in Italia?”. Ognuno ha dato la sua risposta, convincente o meno, lo si scoprirà tra quaranta giorni. Quando tutte le loro richieste di asilo o protezione umanitaria avranno formalmente una risposta.
Uno degli ivoriani è deluso: “Dio è grande, c’è di peggio, ma non è giusto. Conosci Balotelli? Tutti dicono che è pazzo, che ha la testa non buona. Io capisco Balotelli. Io sono cresciuto senza genitori. Non ricordo il volto di mio padre, né quello di mia madre. Sono cresciuto per la strada. La mia testa è un bollitore, è normale che ogni tanto butto fuori acqua. Sembro cattivo, ma dentro sono debole. Oggi mi hanno guardato fuori e non credo abbiano voluto ascoltare quello che sono dentro”.
Sono le 17.30, tutti i ragazzi sono stati interrogati. Esco con l’ultimo e ci incontriamo con gli altri, ci abbracciamo e ci rimettiamo sulla via del ritorno. Via del Corso ha cambiato forma. E’ come la si vede in televisione. Pullula di manichini, dietro le vetrine, davanti le vetrine. Famiglie a passeggio, commercianti, aspiranti modelle, malati di shopping. Giovani a rimorchio. I ragazzi italiani parlano dei problemi di tutti i giorni: “Mi ha chiamato Pincopallino, eh, ma che palle! Se mi fa un’altro pezzo intervieni pure te!” oppure: “Guarda questa oh, gli squillo e non me richiama!”, fino a “Se sabato non troviamo gli ingressi in discoteca faccio un casino”. I richiedenti asilo formulano teorie fantastiche sui loro verbali: “Il tuo ha più pagine, significa che sei andato meglio di me” e “a te hanno fatto meno domande, significa che eri abbastanza sicuro oppure che avevano già deciso?”. Poi iniziano a chiamare i loro amici, a sfogarsi, a riprendere leggerezza. Camminiamo veloce, siamo stanchi, ma più forti di prima. Metropolitana a Flamino e poi l’autobus, alle 19 siamo al Centro, gli faccio: “Che giornata, ragazzi!” e loro: “il giorno più importante della nostra vita”.